Il giorno seguente
in molte località fu proclamato lo sciopero generale e iniziarono i moti della cosiddetta
Settimana rossa, che ben presto si allargano a tutta la Romagna e alle Marche. L’agitazione,
in molte località, prenderà un aspetto d’insurrezione spontanea e popolare, coinvolgendo
centri urbani importanti come Genova, Milano, Parma, Firenze, Napoli, Bari e Roma.
In queste giornate vi furono assalti agli edifici pubblici, saccheggi, sabotaggi
delle linee ferroviarie e ripetuti scontri con le forze dell’ordine. Complessivamente
vi furono 13 morti, uno tra le forze dell’ordine, molte centinaia di feriti e diverse
migliaia d’arresti tra i dimostranti. In Toscana lo sciopero si affermò a Firenze,
Pisa, Livorno, Massa, Carrara, Viareggio, Pietrasanta e Pescia mentre altre province
come Grosseto, Arezzo o città come Lucca furono toccate solo marginalmente dall’agitazione.
Gli incidenti più gravi accaddero a Firenze dopo il comizio in Piazza Indipendenza
quando un consistente gruppo di scioperanti si diresse verso il centro città. Nei
pressi della Manifattura tabacchi i dimostranti venuti a contatto con alcuni agenti
di Pubblica sicurezza tentarono di disarmarli e nel parapiglia venne ucciso dalle
guardie un operaio mentre molti altri rimasero feriti. La città nelle ore successive
vide moltiplicarsi gli incidenti causati dai continui scontri tra operai e forze
dell’ordine che con la forza solo a tarda notte riportare la calma in città. Sotto
la pressione della direzione del PSI, la Confederazione generale del lavoro (CGdL),
il maggior sindacato italiano, proclamò uno sciopero generale di protesta per il
9 giugno, ottenendo però che modi e tempi dell’astensione dal lavoro rispondessero
alle direttive approvate dal Consiglio nazionale nell’aprile 1913, le quali circoscrivevano
ad un limite massimo di 48 ore la durata di un eventuale sciopero generale. 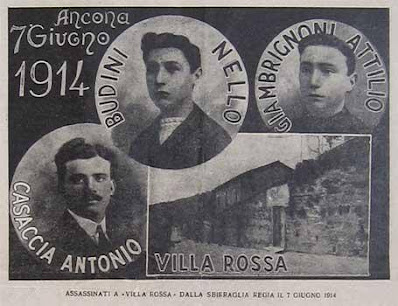
Le organizzazioni
della sinistra dal PSI alla CGdL agli anarchici dell’USI non riuscirono però a dare
un orientamento e uno sbocco politico alla protesta. La direzione del PSI, pur avendo
lavorato per portare la CGdL alla decisione dello sciopero generale, che in molte
località era già stato indetto dalle Camere del lavoro – soprattutto quelle a guida
sindacalista rivoluzionaria –, non volle assumersi la responsabilità politica di
guidare il moto di protesta. Il 10 giugno la CGdL tramite il suo segretario Rinaldo
Rigola, diramò l’ordine di cessazione dell’agitazione mentre lo stesso giorno il
Sindacato dei ferrovieri proclamava l’astensione generalizzata dal lavoro. Le manifestazioni
terminarono tra il 12 e 14 giugno e il governo Salandra potette tirare un sospiro
di sollievo. Le elezioni amministrative indette per la fine di giugno si tennero
regolarmente e il PSI ottenne un importante successo conquistando la maggioranza
in più di 300 comuni, tra i quali Milano e Bologna, e in quattro amministrazioni
provinciali.
La Settimana rossa
lasciò uno strascico di polemiche tra l’ala riformista e quella rivoluzionaria del
PSI. La Settimana rossa, sicuramente, ebbe un ruolo nel determinare l’atteggiamento
della Corona nella decisione di rinunciare ad entrare subito in guerra nell’agosto
del 1914. L’opinione pubblica, le classi dirigenti e le forze popolari non erano
ancora pronte ad affrontare la scelta drammatica della partecipazione italiana al
primo conflitto mondiale. Era assai diffuso il timore che la scelta di entrare in
guerra potesse, in quel momento, scatenare forti reazioni delle masse popolari mettendo
a repentaglio la stessa sopravvivenza della corona e l’integrità dello Stato. Ci
vollero più di dieci mesi, di acceso confronto e scontro tra interventisti e neutralisti,
per portare l’Italia nel coacervo della Prima Guerra Mondiale.

